Ieri Internet, ora YouTube (e prima ancora la radio). Ogni novità nei media è vista come un rattrappimento della capacità di ragionare. Forse è il contrario
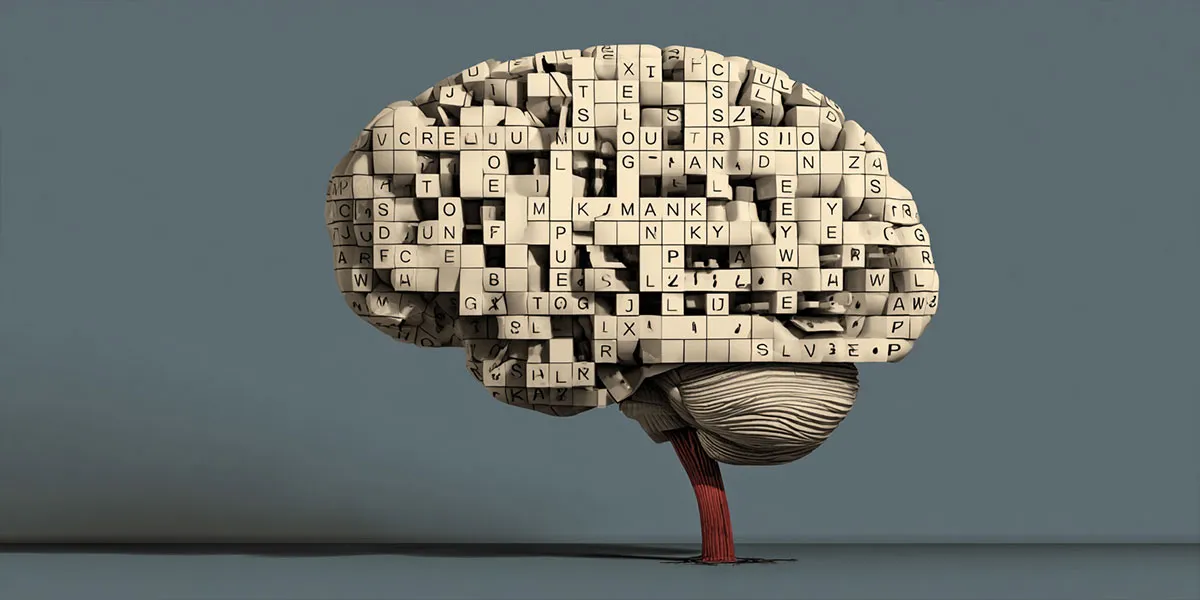
25 Agosto 2025
L'Economia – Corriere della Sera
Alberto Mingardi
Direttore Generale
Argomenti / Teoria e scienze sociali
Nel 2012, il giornalista Nicholas Carr suggeriva che Google «ci stesse rendendo stupidi». Guardando a tutto ciò che Internet offriva, ne deduceva che il web fosse una minaccia alle nostre capacità cognitive.
È un argomento che sembra inoppugnabile, soprattutto ai lettori di quotidiani, specie se lettori di quotidiani di carta. Internet darebbe informazioni in abbondanza, ma più superficiali di quelle fornite dai media tradizionali. Soprattutto, avrebbe trasformato lo zapping, che un tempo si faceva con il telecomando in mano quando il film di prima serata veniva interrotto dagli spot, in un’abitudine universale. Si intercetta una notizia, si legge solo un titolo, poi si passa al successivo. Del resto, la Twitter (adesso X) dell’epoca d’oro consentiva di postare cinguettii non più lunghi di 140 caratteri.i tweet vennero poi allungati a 280 caratteri, secondo l’azienda perché le diverse lingue erano diverse anche in fatto di sintesi e non tutte si prestavano bene allo stile epigrammatico scelto dalla piattaforma. Ma forse una lunghezza maggiore andava incontro pure ai desideri degli utenti.
Discussione pubblica
La critica a Internet in generale e ai social in particolare ne ricorda altre, a innovazioni precedenti: l’ultimo arrivato, fra i mezzi d’informazione, è sempre visto come uno strumento di semplificazione ovvero di impoverimento del pensiero. Negli Stati Uniti si diceva qualcosa del genere già della radio. Queste tesi sono talmente popolari che di solito si fanno strada fra noi senza venire nemmeno scortate da argomenti e prove empiriche. Certo che i social sono responsabili del rattrappimento della discussione pubblica, chi mai lo metterebbe in dubbio?
Qualche settimana fa Ted Gioia, che è un pianista jazz e un critico musicale di vaglia, ha postato sul suo Substack alcune considerazioni molto interessanti. Partivano da un’indagine condotta presso il pubblico americano, per il quale Youtube è sempre più una delle primarie fonti d’informazione (non è detto che non sia così anche da noi, in particolare modo fra i più giovani). Soltanto il 13,7% degli utenti di Youtube consuma video più corti di un minuto, il 16% video di lunghezza compresa fra uno e dieci minuti, il 13,1% video lunghi fino a 20 minuti e il restante 57,2% contenuti più lunghi di venti minuti. Va da sé che in venti minuti può starci una serie di sketch comici più demenziali l’uno dell’altro, una lezione di Alessandro Barbero, o immagini di gattini che vanno in loop l’una dopo l’altra.
Negli anni scorsi ci siamo raccontati che le persone fanno sempre più fatica a essere concentrate e si distraggono sempre prima. Fior di pedagogisti hanno spiegato a una generazione di giovani docenti universitari che persino le loro lezioni dovevano acconciarsi allo spirito del tempo: quindi essere costruite su blocchi lunghi attorno ai cinque minuti, intervallate da qualche diversivo, se possibile visivo, per provare a rinsaldare l’attenzione dei ragazzi.
Consumi culturali
La lunghezza dei prodotti culturali che consumiamo non è indicatore perfetto, ma suggerisce che se qualcosa ci interessa siamo in grado di concentrarci su di essa per un certo lasso di tempo. Gioia giustamente fa il caso del cinema hollywoodiano, che tende a produrre blockbuster sempre più lunghi. «Oppenheimer» durava oltre tre ore, l’ultimo «Mission Impossible» due ore e cinquanta minuti, il secondo «Dune» poco meno.
Qualcosa di simile può essere osservato nella musica. Nell’ultimo anno, la top ten del sito Billboard ha registrato nel 2024 una maggiore lunghezza in media di venti secondi a canzone (che sui quattro minuti di un pezzo pop non è poco). Secondo Gioia, se guardiamo alla durata media di un album di Taylor Swift (il più grande fenomeno della musica leggera dei nostri tempi), vediamo che nel coso degli anni la lunghezza si dilata, dal che possiamo dedurre che i suoi fan preferiscano raccolte di canzoni più lunghe. L’ultimo album, Tortured Poets Department, dura due ore.
Se guardiamo ai romanzi, dobbiamo constatare che da anni i best-seller sono sempre più lunghi. Sui siti e sui blog gli articoli d’informazione, poi, sono più ampi che sui giornali di carta.
La lunghezza è qualità? Non necessariamente. Ma segnala che forse il destino della nostra attenzione non è segnato come si pensava. Secondo Gioia, si tratta di una «reazione» allo «scrollare» digitale equivalente dello zapping televisivo. Gioia inoltre ritiene che l’iperbrevità non funzioni bene nel cementare quella «lealtà» a un certo artista (o scrittore) che solo invece contenuti di forma più lunga possono sviluppare. Sette anni prima del saggio di Carr, un altro giornalista, Steven Johnson, pubblicava un libro con una tesi opposta. In «Tutto quello che ti fa male ti fa bene», Johnson azzardava che la crescente complessità dell’intreccio delle serie televisive (o della struttura dei videogiochi) poteva avere un effetto positivo, non negativo, sulle nostre capacità cognitive. Il libro ebbe poca fortuna, perché il pessimismo massmediologico è sempre sulla cresta dell’onda. Solo che anche gli errori prospettici sono sempre i medesimi. Noi tendiamo a considerare (l’abbiamo fatto con la tv generalista e continuiamo a farlo ora) l’entertainment una droga per il nostro cervello. Invece forse è un tapis roulant, che costringendoci a seguire le troppe storie che s’intrecciano nella trama del «Trono di spade» lo allena.