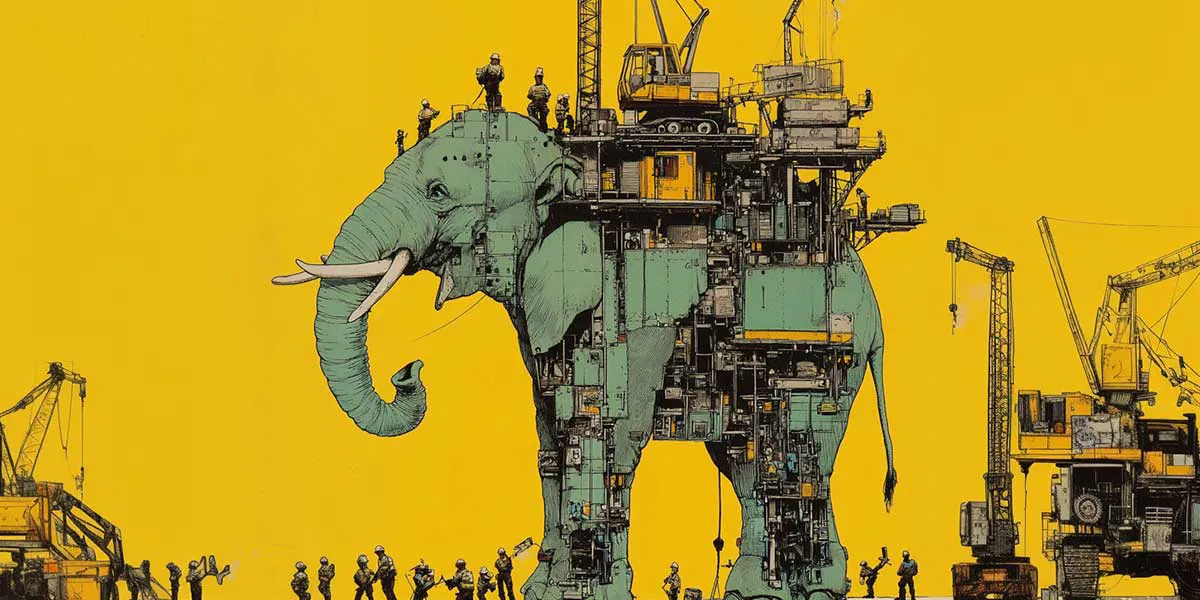
19 Maggio 2025
Corriere Economia
Alberto Mingardi
Direttore Generale
Argomenti / Diritto e Regolamentazione
Fra poche settimane andremo a votare per dei referendum il cui obiettivo è cancellare trent’anni di politiche del lavoro. Questi referendum cadono in corrispondenza quasi perfetta con il trentesimo anniversario di altri referendum, che nel 1995 cercavano di ridimensionare il ruolo dei sindacati maggiori (la «Triplice»).
Ma la premessa logica, più o meno dichiarata, che portò i radicali e il centro destra a convergere su referendum che erano partiti dai sindacati minori, era che lo strapotere di Cgil, Cisl e UIL avesse conseguenze anche sulla possibilità di creare lavoro. I referendum del prossimo giugno partono da una premessa di segno opposto. Il loro obiettivo è il Jobs Act, con il quale il governo Renzi fra l’altro abolì l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e cambiò la disciplina degli indennizzi. Quella norma è stata poi parzialmente «svuotata» dalla Corte costituzionale e dal decreto «dignità». Ciononostante, per esempio secondo uno studio di Gabriele Ciminelli e Guido Franco, ha contribuito positivamente alla produttività totale dei fattori. Questo perché le rigidità del mercato del lavoro ostacolano il passaggio delle persone verso compiti nei quali sarebbero più produttivi.
Oggi il numero degli occupati e il tasso di partecipazione al mercato del lavoro hanno raggiunto il massimo dacché disponiamo di statistiche comparabili. Il tasso di disoccupazione è al 6%, il livello più basso dal 2007. L’Italia aveva raggiunto la piena occupazione nel 1964, con solo i14% dei disoccupati. Questo fatto cambiò i rapporti di forza, si sarebbe detto un tempo, fra capitale e lavoro: se i disoccupati sono molti, il potere contrattuale dei lavoratori è scarso. Se sono pochi, è elevato. Il «naturale» riequilibrio delle forze in campo venne però inevitabilmente politicizzato. L’esito fu lo Statuto dei lavoratori, per citare un simbolo (e le battaglie referendarie di ieri e di oggi sul terreno simbolico si combattono).
Le tutele funzionano per chi un posto già ce l’ha, ma hanno conseguenze indesiderate: diminuiscono la propensione delle imprese ad assumere, riducendo le opportunità per chi un posto non ce l’ha ancora. Il famoso articolo 18 divenne uno straordinario disincentivo alla crescita dimensionale delle imprese (non si applicava a quelle con meno di 15 dipendenti), che preferirono restare formalmente piccole e arrangiarsi con altre strategie di collaborazione, anziché ampliarsi. Del resto, assumere il sedicesimo dipendente voleva dire sposare lui e i precedenti 15, senza possibilità di divorzio.
Le cause
Non è l’unica causa, ma fatto sta che dalla seconda metà degli anni Settanta il tasso di disoccupazione cominciò ad aumentare, stabilizzandosi su valori attorno al 12% medio, con ampie differenze tra Nord e Sud. Poi qualcosa è cambiato. Nel 1995 si votò per 12 referendum. I quesiti sui sindacati, tre su quattro (incluso quelle sulle trattenute) vinti dagli avversari della Triplice con percentuali attorno al 6o%, forse non ebbero un impatto immediato ma incisero sulla cultura politica. Il governo Dini, quell’anno, aveva già affidato al Parlamento il cosiddetto «pacchetto Treu», che introduceva flessibilità nel mercato del lavoro. L’Ulivo, che vinse le elezioni l’anno successivo proseguì su quella linea. E la tesi 43 del programma della coalizione di Romano Prodi prevedeva buona parte di ciò che poi è stato faticosamente realizzato nei vent’anni successivi: formazione continua, riduzione del cuneo fiscale, costruzione di strumenti per un miglior matching fra domanda e offerta di lavoro, flessibilità salariale, più spazi per il lavoro a termine e il part time necessari per accrescere la partecipazione al lavoro in un Paese in cui essa era molto bassa.
Dopo sono venute la legge Biagi, la contrattazione decentrata e l’articolo 8, la legge Fornero, il Jobs Act. Provvedimenti non del tutto coerenti l’uno con l’altro, ma che segnalano una politica pubblica che ha seguito a lungo lo stesso indirizzo di fondo e che ha conseguito risultati nel complesso straordinariamente positivi: più occupati, maggiore partecipazione al mercato del lavoro, minore disoccupazione.
È abbastanza singolare che a voler segnare una cesura con il recente passato siano le stesse persone che con un altro referendum propongono di ridurre i tempi per ottenere la cittadinanza italiana. Un mercato del lavoro più ingessato offre più tutele agli insider ma complica la vita agli outsider. Chi ha più da perderci sono allora proprio gli outsider assoluti: quegli immigrati che si troverebbero a combattere, oltre al pregiudizio, anche normative più ostili al loro ingresso nel mondo del lavoro.