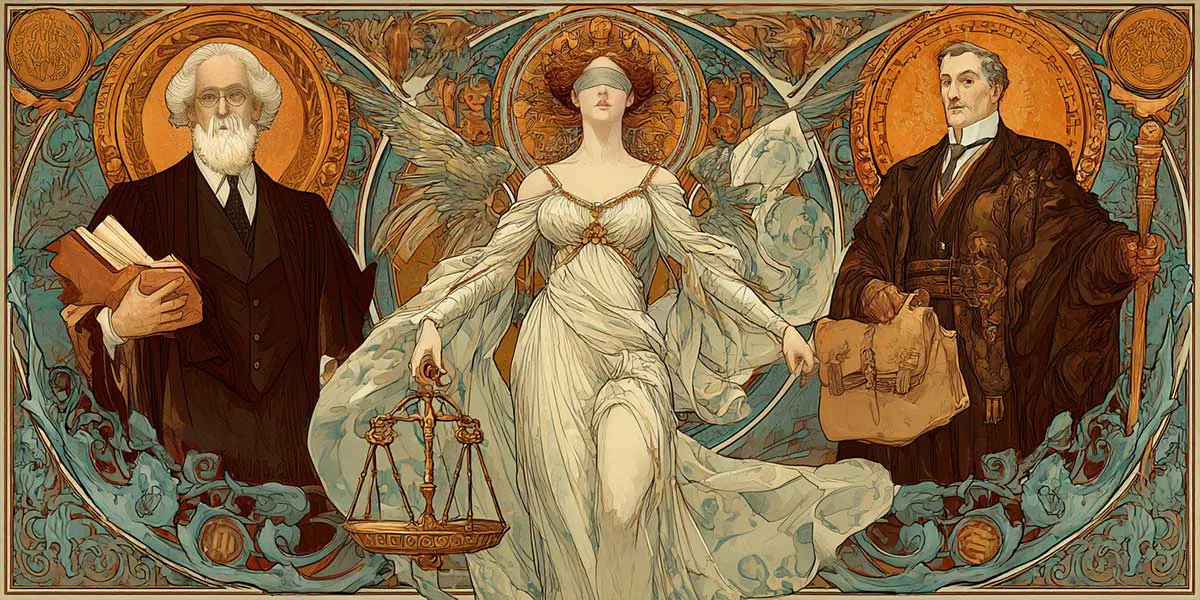
Sono quasi trent’anni, dalla Commissione D’Alema del 1997, che la separazione delle carriere dei magistrati è oggetto di attenzione politica e tentativi di riforma costituzionale. Mai come ora si è andati vicini allo scopo, anche se le riforme legislative che si sono succedute in questi anni, da quella Mastella a quella Cartabia, hanno reso più difficile il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante. Resta l’ultimo miglio, dall’esito non scontato. Il referendum costituzionale è infatti per sua natura di opposizione. È vero che viene definito anche referendum confermativo, poiché chiede agli elettori se vogliono confermare o meno la riforma approvata in parlamento. Ma, dal momento che non ha quorum di partecipazione, bastano pochi no espressi per superare molti sì taciti.
Se si tiene a mente questo, se ne possono trarre due lezioni, una più facile e una più difficile. Cominciando da quella facile, non ha molto senso che a proporlo sia la stessa maggioranza di governo. Non ce l’ha dal punto di vista democratico, proprio perché il referendum costituzionale è uno strumento di voce delle minoranze, tanto che è nella loro disponibilità chiederlo. Potrebbe non averlo nemmeno dal punto di vista strategico, poiché, data la mancanza di quorum, l’aggiunta di un obiettivo plebiscitario potrebbe non valere il costo e il pericolo di una battaglia politica che di norma lascia a casa chi non ha un convinto “no” da esprimere. E invece la maggioranza ha dato il via alla procedura prima anche delle opposizioni, aprendo la strada, per venire alla seconda e difficile lezione, alla trasformazione del voto referendario in un voto politico. Meloni, certo consapevole del rischio sopra detto, sembra non aver ancora deciso se intestarsi la campagna referendaria. Da un lato, c’è lo spettro del precedente Renzi; dall’altro, sa che farlo potrebbe essere un modo per portare alle urne i voti favorevoli non alla riforma, che a molti non interessa o non interessa capire, ma al suo partito, cioè a lei.
Certo, non si può chiedere né al governo né all’opposizione di non deviare dal testo della riforma agli slogan della politica. Chi tra i politici vorrà parlare di questa e non del rumore intorno, sarà qualche lodevole eccezione, come nel caso dell’onorevole Marattin e del suo comitato per il Sì. Si può però, anzi si deve chiedere a chi a diverso titolo è coinvolto nell’informazione referendaria di stare sul merito. A giornalisti, accademici, interpreti del diritto tocca l’onere di provare a portare su questo livello la discussione. Vale anche per le associazioni dei magistrati, per le quali, essendo coinvolte, la necessità di un confronto franco è ancora più indispensabile. Per stare quindi sul merito, la riforma introduce quattro punti essenziali: definitiva separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri; separazione del sistema di autogoverno in due Csm, formati per sorteggio tra giudici, professori e avvocati in possesso dei requisiti richiesti; deferimento delle questioni disciplinari a un terzo organo distinto, l’Alta corte disciplinare.
Chi non sostiene la bontà della riforma lo fa per due motivi: o la ritiene sbagliata o la ritiene inutile. Tra chi la ritiene sbagliata, la critica più fondata è quella per cui, se l’obiettivo è quello di correggere l’autocrazia della magistratura e in particolare il potere dei pubblici ministeri, andato negli anni al di là di quanto necessario a svolgere la loro funzione, la creazione di due Csm separati potrà avere l’esito non di dimezzare, ma di doppiare le degenerazioni dell’autonomia. Questo argomento però si può superare solo superando l’inquadramento dei Pm all’interno della magistratura. L’unica soluzione sarebbe “alla francese”, cioè subordinarli al governo, soluzione impraticabile. Poiché l’ottimo è nemico del bene, se la questione è contrastare il fenomeno del correntismo e del corporativismo, la separazione di sistemi di autogoverno e l’introduzione del sorteggio sono meglio dell’attuale concentrazione in un unico Consiglio di natura elettiva, senza che siano compromesse né l’autonomia né l’indipendenza dei magistrati. Difatti, non si vede come possa costituire un attacco all’indipendenza della magistratura dividere la carriera tra Pm e giudici mantenendo l’autogoverno degli uni e degli altri, a meno di non voler ammettere che l’indipendenza sia stata, finora, sinonimo di corporativismo. Inoltre, è difficile sostenere che il sorteggio minacci l’autorevolezza del Csm, senza mettere in dubbio anche la professionalità dei sorteggiabili.
Chi ritiene invece inutile la riforma, poiché il passaggio di carriere è già ora difficile e raro, sottovaluta che la terzietà del giudice e l’equilibrio nello svolgimento del proprio ruolo non derivano solo dal fatto concreto, ma anche dal fatto percepito che la magistratura requirente svolge una funzione diversa da quella giudicante. Lo stesso vale per il sorteggio: è vero che le correnti possono crearsi o ad esse si può aderire anche dopo essere stati estratti. Tuttavia, l’introduzione di un sistema non elettivo aiuta ad allontanare quel fenomeno esiziale di un correntismo persino accreditato dentro e fuori la magistratura. Una separazione definitiva delle carriere, con un autogoverno meno politicizzato, può aiutare a distinguere le funzioni di chi esercita l’azione penale e di chi emette sentenza e restituire, dentro e fuori dall’ordine, la consapevolezza di una reale indipendenza anche dalle correnti interne. Può aiutare, quindi, ad uscire dalle ambiguità che hanno contribuito a un insano rapporto tra politica, magistratura e opinione pubblica.