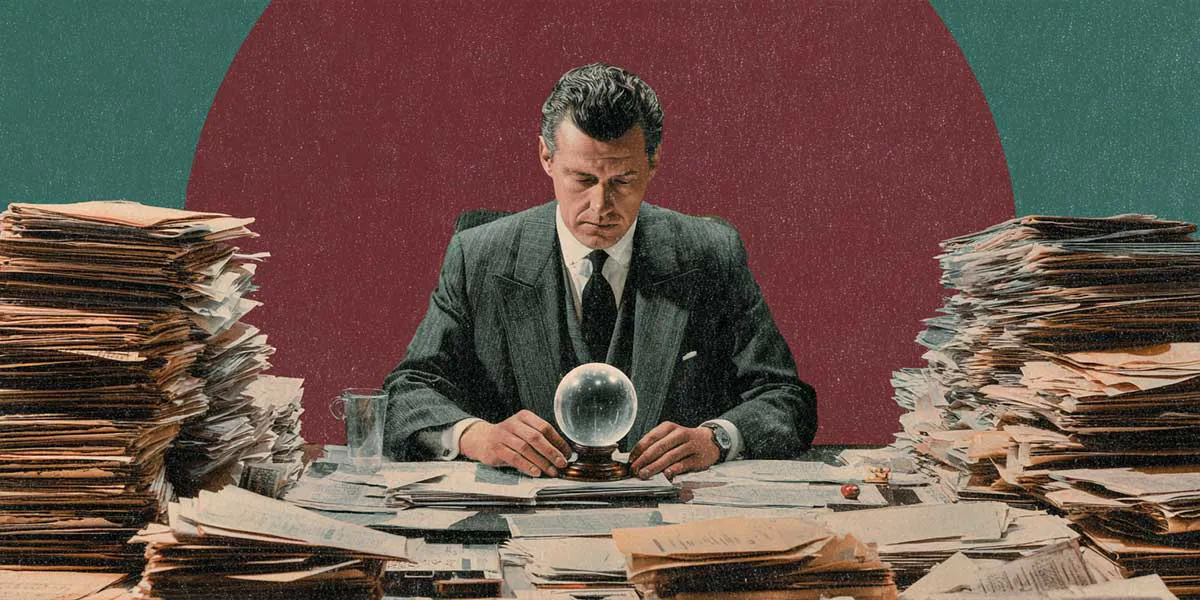
D’ora in poi, gli atti normativi del governo, ad eccezione dei decreti legge, dovranno contenere un’analisi preventiva sugli effetti sociali e ambientali a carico o a beneficio dei giovani e delle generazioni future, in nome dell’equità intergenerazionale. È la Vig (valutazione di impatto generazionale), che entra come scheda di un’altra scheda esistente, l’Air (analisi di impatto della regolamentazione), alla quale dovrebbe far seguito la Vir (verifica di impatto della regolamentazione).
Se sembra complicato, è perché lo è. Una considerazione dell’impatto intergenerazionale delle politiche pubbliche è un’esigenza giusta e avvertita. Ma non può essere liquidata in un’analisi in calce ai provvedimenti, per alcune ragioni pratiche e una generale.
Quanto alle prime, per apprezzare una tecnica del genere andrebbe prima capito come, con quali strumenti e metodologie condurre la verifica. Di buone intenzioni è lastricata la via della burocrazia e della tecnocrazia, e la Vig, esattamente come l’Air e la Vir (quando fatte), non sfugge ai pericoli né dell’una né dell’altra.
C’è poi un dubbio più essenziale, e cioè che questa valutazione sia utilizzata per dare una copertura di maniera a scelte già prese anziché per offrire uno strumento di maggior riflessione prima che esse vengano adottate. L’applicazione, peraltro saltuaria, dell’Air dimostra il rischio di autoassoluzione. È quanto rimproveriamo anche ai decreti legge, i cui motivi di straordinaria necessità e urgenza servono spesso a giustificarne l’esistenza anche quando non ci sono né la straordinarietà né l’urgenza.
Se così dovesse succedere, la Vig rischierebbe non tanto di essere inutile, quanto di consentire ai governi di navigare nel presentismo facendo finta di preoccuparsi del futuro. Tanto più in carenza di una chiara programmazione politica e di un’amministrazione formata alla valutazione delle politiche pubbliche.
Ci sono poi altri aspetti che rendono la Vig facile solo a dirsi. Per dirne solo alcuni, i concetti stessi di “giovani” e “generazioni future” sono controversi e rischiano di intrappolare le complessità in gruppi astratti, di cui ci prendiamo paternalisticamente cura senza poter conoscere, oggi, quali possano essere i reali bisogni di domani. In breve, valutare l’impatto nel lungo termine richiede una capacità predittiva sia di quali saranno le variabili del domani, sia di quali saranno le aspettative e le preferenze delle più giovani generazioni e persino di quelle che verranno. L’innovazione, ad esempio, ha smentito che la risorsa agricola sia proporzionale alla quantità di terra a disposizione. La più recente vicenda pandemica ha dimostrato una capacità di reazione, a partire dalla vaccinazione, che non avremmo immaginato col metro delle precedenti pandemie.
La valutazione che si vorrebbe introdurre, inoltre, riguarderebbe solo gli effetti ambientali e sociali, non anche finanziari, quando invece la scarsità delle risorse economiche è uno dei problemi quotidiani che i governi devono affrontare. Ancora, la Vig non si applica ai decreti legge, che rappresentano la parte più consistente della produzione legislativa.
Al di là di queste ragioni più pratiche e specifiche, c’è poi quella generale. Presa sul serio, l’equità intergenerazionale va oltre le tecniche di redazione delle norme e riguarda la capacità di auto-controllo di chi governa. Se questo sacrosanto principio vuole essere un credibile vincolo all’indirizzo politico, deve valere prima di tutto come genuino riconoscimento dei limiti cognitivi e realizzativi del governo, quale che ne sia la maggioranza.
Più che della Vig, quella che occorre, come sempre, è un’assunzione di responsabilità del circuito politico, che si faccia quotidiano carico di una ordinaria valutazione, per quanto possibile, dei costi e dei benefici nel tempo delle sue scelte, allontanando da sé le sirene del consenso immediato.