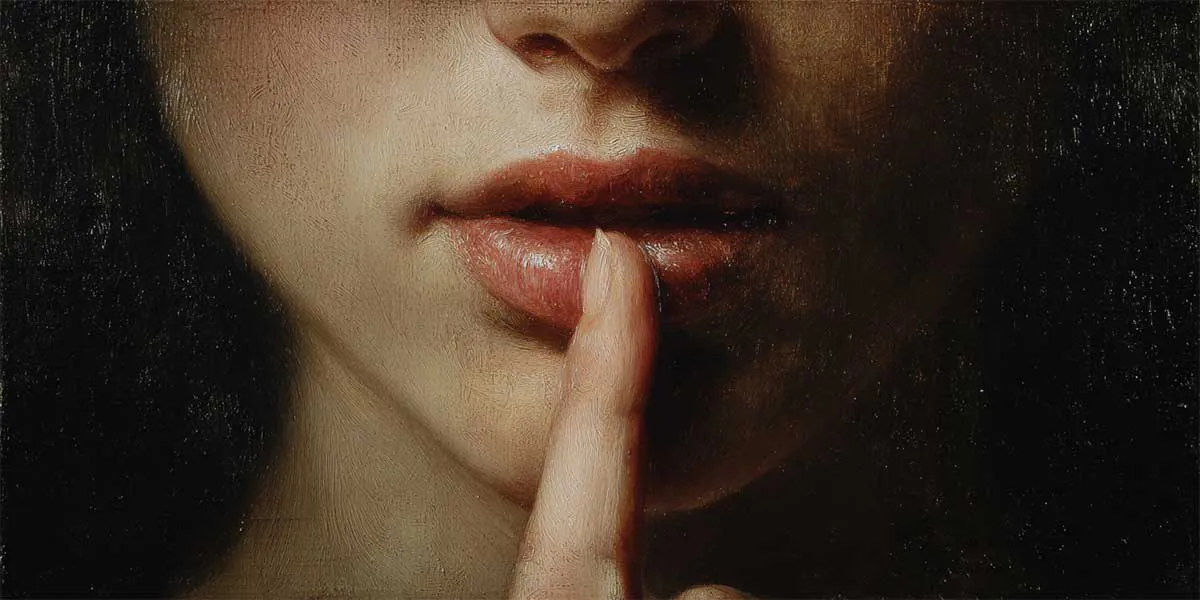
Pini Zorea, professore di una università israeliana ospite del Politecnico di Torino per un corso di dottorato, è stato sospeso dall’attività didattica per aver affermato in aula che l’esercito israeliano è il più corretto al mondo. Ognuno si farà da sé un’opinione su quanto possa essere sbagliata l’esternazione. E’ però certo che – in una Repubblica dove «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento» – essa non può essere, come l’ha definita il rettore del Politecnico, «inaccettabile». E non lo è non per il suo valore intrinseco, ma perché, buone o cattive, tutte le idee in un Paese libero sono accettabili.
La libertà di insegnamento, poi, che è attività personale e non della scuola o dell’università dove si presta servizio, è persino più grande di quella di pensiero. L’alternativa, infatti, sarebbe l’insegnamento condizionato, se non imposto, da qualcuno (il ministero, il dirigente scolastico) o qualcosa (la legge, le circolari). Un pericolo che noi figli e nipoti della democrazia nata dopo il fascismo dovremmo capire al volo e ricacciare senza tanti distinguo.
Naturalmente, ci sono cattivi insegnamenti e cattivi maestri, in aula e fuori. I giudizi sull’attualità sono oltretutto un campo minato. Quello che nella storia è sedimento, nell’attualità è movimento. Più riguardano quello che ci circonda, più le nostre opinioni, simpatie, esperienze influenzano le nostre convinzioni. Ma proprio la libertà di insegnamento permette di farci più di un’idea, di sentire più di una versione, ascoltare e studiare punti di vista diversi, anche eccentrici e minoritari, evitando la tirannia del pensiero unico. Che è il modo più sano, libero e democratico di sopravvivere alle idee sbagliate.
Martedì, durante la sua prima lezione del nuovo anno accademico a Pisa, il prof. Rino Casella veniva interrotto dall’irruzione di un gruppo ProPal, con tanto di aggressione fisica, per aver criticato la sua università dopo la sospensione della collaborazione con due atenei israeliani.
Nel mondo dell’ovvio, i due episodi sono di una differenza evidente. Nel primo caso, un docente ha subito un trattamento disciplinare per l’esternazione di un’opinione. Nel secondo caso, in nome di una “causa”, un docente è stato aggredito.
Non importa, qui, giudicare le due idee sulla base di quel che sostengono. Importa ricordare una delle cose più scontate della nostra civiltà, che appare oggi più in pericolo che mai: un’idea, di per sé, non può mai mettere in pericolo la pacifica convivenza. Ciò che la rende pericolosa, e quindi inaccettabile, è un elemento esterno ad essa: il grado di violenza con cui può essere diffusa.
Da molti anni, la retorica dell’hate speech ha avvelenato i pozzi della libertà di espressione e di insegnamento. I discorsi odiosi saranno pure detestabili, sul piano intellettuale e morale, ma ritenerli illeciti, sul piano legale o disciplinare, vuol dire consegnare a qualcuno che ha un potere di comando su di noi l’autorità di dirci cosa è giusto o sbagliato dire.
Quanta distanza c’è, allora, tra sospendere un docente per quel che ha detto e chiedergli un giuramento di fedeltà? Quanto lontane sono le forme di censura a quella reticenza che – dagli oggi, dagli domani – applichiamo più o meno consapevolmente alle nostre esternazioni? Quale differenza c’è tra una censura pubblica e istituzionalizzata e la pressione privata, esercitata dai livelli manageriali e direzionali, nel dirci cosa possiamo dire senza rischiare il posto di lavoro o per essere assunti?
A queste domande, il pensiero occidentale ha dato risposte inequivocabili. Da anni, tuttavia, una degenerazione progressiva del rispetto di chi ha un’idea diversa dalla nostra, della capacità di riconoscere l’altro nella sua individualità prima che nei gruppi in cui lo identifichiamo è diventata una caccia alle streghe, un elemento di esclusione, persino di auto-esclusione.
Qualche giorno fa, il professor Francesco Tuccari, presidente uscente dell’associazione italiana di storia del pensiero politico, davanti all’alternativa tra portare avanti una mozione di condanna del genocidio a Gaza col nuovo direttivo o rinunciare alla ricandidatura, ha preferito cedere comunque il passo e non strumentalizzare (o essere strumentalizzato da) qualsivoglia “causa” alla candidatura, peraltro unica, alla presidenza di un’associazione di professori.
Kirk è morto per le sue idee e la sua morte per una parte dell’opinione pubblica ha un peso diverso proprio a causa di quelle idee, in quanto sbagliate. Al tempo stesso, chi vuole vendicarla è pronto, come ha detto la procuratrice generale degli USA Pam Bondi, a prendere di mira e perseguire chi si impegna in discorsi d’odio, invitando i datori di lavori a licenziare chi dice cose orribili.
L’America, questa America è lontana. Eppure anche da noi, nelle culle della libertà di ricerca e insegnamento che sono le università, c’è chi di idee ferisce e in nome delle idee viene zittito.