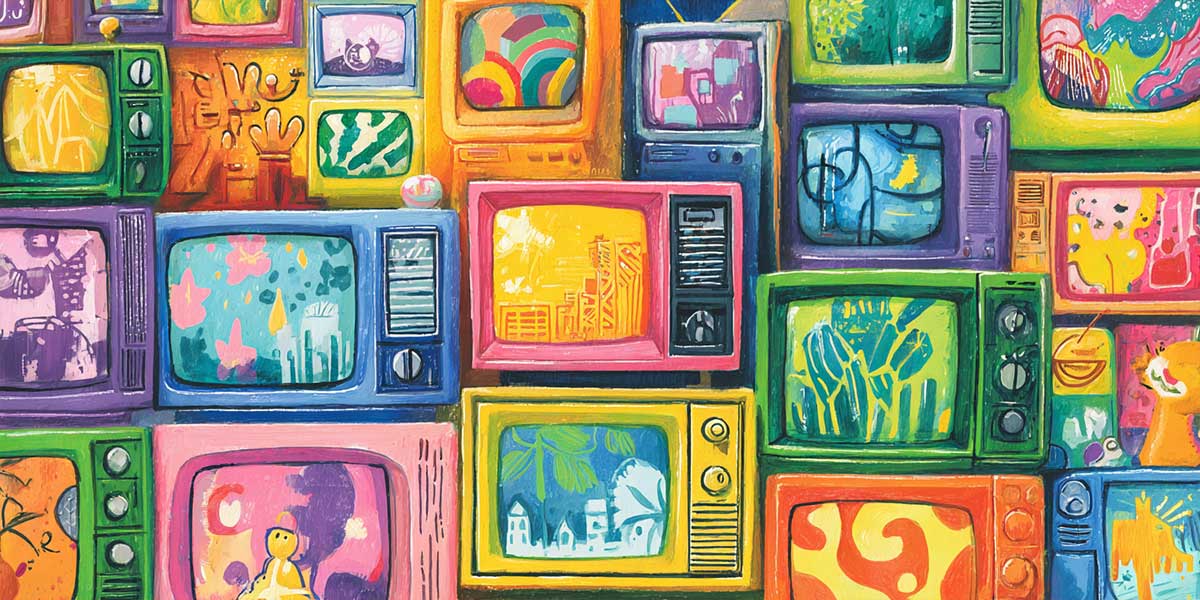
Con esagerata modestia, o calcolato understatement, Alberto Mingardi esordisce definendosi «dilettante» nel maneggiare la storia degli eventi rispetto a quella delle idee, insegnata nelle aule universitarie. In realtà, la ricostruzione di ciò che avvenne nel fatale 1995, l’anno dei dodici referendum (tutti premiati dal raggiungimento del quorum), è puntuale, approfondita e incalzante; e si allarga necessariamente alla storia della Tv e della Rai in Italia, e a ciò che entrambe hanno rappresentato: nel bene (il cambiamento che provocò nella società italiana), e nel male (il cambiamento che provocò nella società italiana).
La reiterazione non è un lapsus perché allo stesso argomento ricorrevano i tele-entusiasti e i tele-pessimisti; i primi per enfatizzare la crescita di libertà che si accompagna a ogni nuova tecnologia di diffusione del sapere e delle informazioni; i secondi per preconizzare i peggiori disastri dall’appiattimento della cultura che quegli strumenti avrebbero determinato (come già avevano denunciato gli intellettuali di epoche remote, quando erano apparse scrittura e stampa). E ancora più paradossale appariva, e risultò, che per difendere le masse dall’intorpidimento si volesse penalizzare qualunque forma di pluralismo, e difendere a spada tratta il monopolio della Rai (a sua volta denunciata dagli stessi per anni, quando Berlusconi non era all’orizzonte, come strumento di indottrinamento della Dc).
Un monopolio che non aveva più ragione, se non quello, appunto, di manifestare il peloso «paternalismo» (denunciato da Sergio Ricossa nelle sue vesti di presidente del Comitato per il “no”) di chi, proclamando l’ottima intenzione di difendere i meno accorti, proteggeva robuste rendite di posizione e consolidati assetti di micro-poteri.
A questo atteggiamento oscurantista e apocalittico di tanti intellettuali contro la tv (e la pubblicità) Mingardi dedica forse le pagine più sferzanti. E attuali: perché quell’atteggiamento dimostrò quanto una larga fetta delle élite culturali fosse (sia?) ancora lontana dal chiudere i conti con la questione della cultura di massa, questione che, se considerata espressione di una insuperabile inferiorità antropologica, rischia di deflagrare in scelte collettive inattese ed esplosive. Ricordate il più recente «basket of deplorables» della signora Clinton che ci ha regalato otto anni del presidente Trump?
È proprio quanto accadde quell’11 giugno di trent’anni fa, quando gli italiani, forse una tra le prime volte, tradirono i sondaggi e votarono allegramente per consentire le interruzioni pubblicitarie nei film, non smontare il duopolio Rai-Fininvest, permettere a quest’ultima di continuare a raccogliere pubblicità. In questo senso, commenta Mingardi, davvero quei referendum «sono stati uno dei punti di svolta dell’Italia contemporanea».
Lo furono, aggiunge in conclusione, perché quel voto, se rimise saldamente in sella Berlusconi pur senza offrirgli le motivazioni per compiere la rivoluzione liberale che aveva promesso, cambiò la sinistra, che assunse un atteggiamento meno dogmatico e più attento alle urgenze, e ai sentimenti profondi, del Paese. Lo fece mettendo anche mano a riforme che «piacciano o meno, hanno cambiato l’Italia». Ed è un peccato, aggiunge, che quella svolta, oggi, appaia spesso a gran parte della stessa sinistra come «una sorta di aberrazione, un errore da farsi perdonare, il patto con il diavolo del neoliberalismo» (l’ultimo referendum insegna).
Mentre Berlusconi, in realtà, la scelta liberale l’aveva fatta prima, scrive Mingardi, magari inconsapevolmente e non necessariamente animato da profondissime velleità ideologiche: l’aveva fatta, appunto, con le sue televisioni commerciali che avevano ampliato le possibilità di scelta e dunque lo spettro di libertà effettiva di ogni cittadino.
Qui, tra l’altro, l’autore smonta l’argomento, abusato oggi come allora, che quelle tv siano necessariamente strumento di rimbambimento e di indottrinamento; in realtà, scrive criticando anche Popper e Sartori, avviene spesso l’inverso: sono i patiti di politica che s’informano per trovare «irrobustite le proprie convinzioni, non di farsele da zero».
Le “camere dell’eco”, insomma, ci sono sempre state; e allora la strada resta quella lungo la quale si è costruita la democrazia liberale: difendere il pluralismo, combattere i monopoli, non ammanettare le tecnologie e adesso, orrore supremo, prendere atto che perfino la televisione, perfino quella infarcita di spot, può ancora rappresentare coi giornali (ripensati) un argine potente contro la spazzatura informativa.
Alberto Mingardi, Meglio poter scegliere. I referendum del 1995 e la battaglia per la televisione commerciale (Mondadori, 2025, 420 pp.)