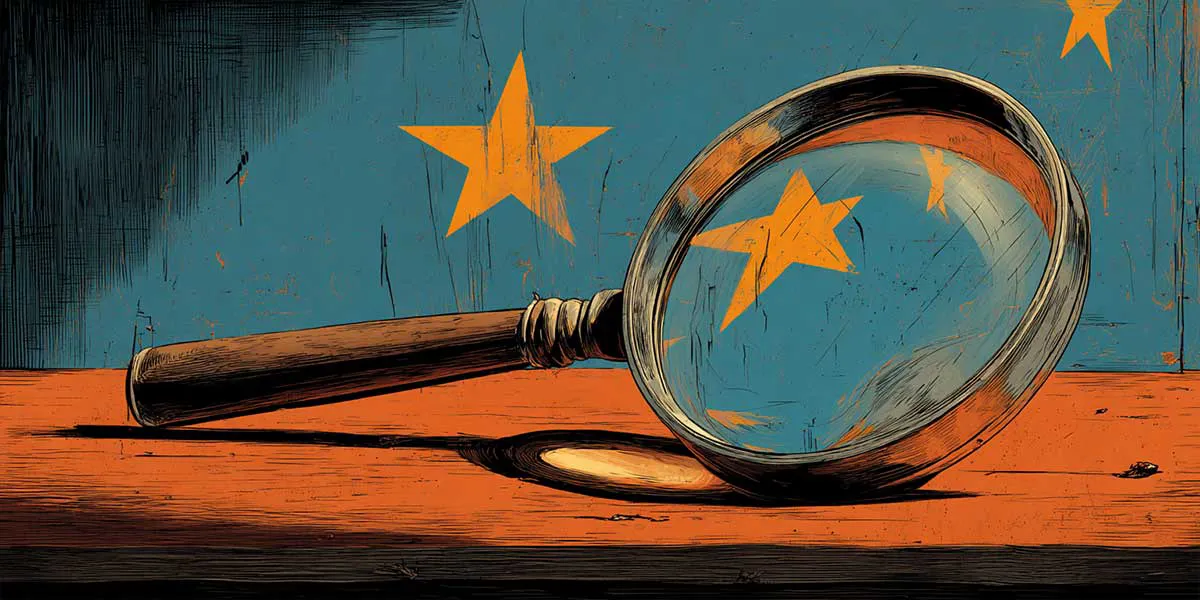
L’Unione europea si espande per territorio e si intensifica per integrazione. Questa settimana la Commissione ha adottato il suo pacchetto annuale sull’allargamento, che monitora i progressi nel cammino di adesione degli Stati candidati. I paesi coinvolti sono Montenegro, Albania, Repubblica Moldava, Serbia, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Turchia, Georgia e, ovviamente, Ucraina.
Si può pensare per mille motivi che l’Unione europea stia attraversando una profonda crisi istituzionale. Alcuni di essi sono endogeni: lo stesso allargamento, passato e futuro, ha portato con sé una serie di debolezze, dalla perdita degli obiettivi iniziali a disfunzionalità organizzative. Altri sono esogeni e riguardano la difficoltà di affrontare oggettivi problemi sociali, economici, demografici e di rapporti internazionali.
Nonostante tutte queste difficoltà, cercate o capitate, l’Ue è un sistema economico e giuridico sempre più compenetrato con quello nazionale. Il Next Generation EU ha rappresentato uno spartiacque nel modo in cui funzionano i rapporti tra l’Unione, gli Stati e i cittadini, senza che siano stati modificati i Trattati, ma anzi forzandone l’interpretazione.
Tra un anno si chiuderanno i Pnrr nazionali. Quello italiano, il più consistente di tutti, ancora oggi giustifica l’aumento (per ora) del Pil del nostro Paese. Un giorno dovremo ricominciare a ripagare buona parte del debito che l’Europa ha fatto per noi e capiremo se ne sia valsa la pena. Potremo anche capire se il vincolo del 40% di spesa complessiva al Sud sia stato una buona idea.
Al momento, il governo è ancora impegnato a verificare che i soldi vengano spesi, prima che se lo siano in maniera efficace. Ad esempio, il valore della quota Sud per ora è ancora inferiore al 40%, fermandosi a poco più del 37%. Nel Def su cui poggia la prossima legge di bilancio, una parte del finanziamento Pnrr viene dirottata per coprire spese già sostenute, ammettendo così che gli investimenti che restano scoperti o non sono fattibili o non sono una buona idea.
Criticità, opportunità e bilancio del piano Next Generation EU in questi anni sono diventati oggetto anche di numerosi studi accademici. A Napoli, in particolare, il Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche dell’Università Suor Orsola Benincasa ha istituito nel 2023 la cattedra Jean Monnet NextGEUOrder come strumento di analisi, didattica e ricerca ad ampio raggio e da diverse angolazioni di studio, nella convinzione che l’eredità del Pnrr si misurerà sul legato istituzionale e politico in pari valore rispetto a quello economico.
Iniziare a comprendere sin da ora la portata e le conseguenze future di questo programma così rivoluzionario (anche perché necessitato dall’imprevedibile emergenza pandemica del 2020) rispetto alla storia della Ue può consentire un approccio più ordinato a una maggiore integrazione europea di fatto, una realtà che circonda e condiziona le nostre vite molto più di quanto non immaginiamo.
Su questi temi l’Università Suor Orsola Benincasa ha anche pubblicato nella sua collana editoriale de I Quaderni della ricerca un ampio volume dal titolo quanto mai eloquente What’s next after next, che raccoglie contributi multidisciplinari di autorevoli studiosi di diversi atenei italiani e di alti funzionari che hanno lavorato al programma Next Generation EU.
Il libro, disponibile in open access (https://universitypress.unisob.na.it), analizza anche e soprattutto alcune delle principali conseguenze del NGEU sull’assetto costituzionale nazionale ed europeo. Ed è ormai evidente che l’eredità del Next Generation EU non si misurerà solo nel suo impatto economico.
Alcune iniziative successive hanno già utilizzato il metodo del Pnrr (impegni di riforme e investimenti in cambio di finanziamenti) per forzare ciò di cui l’Unione europea non si dovrebbe occupare: politiche pubbliche nazionali, difesa, guerra. Segnali di questo metodo vi sono in primo luogo nella riforma del Patto di Stabilità ma anche in ulteriori programmi sull’ambiente, come RePowerEU e il Fondo sociale per il clima.
La Commissione vorrebbe modellare lo stesso piano pluriennale di bilancio — cioè quanti soldi pubblici europei saranno spesi e come — sull’approccio “un piano nazionale per Stato membro”. Quando il NGEU fu approvato, la presidente della BCE propose di mantenerlo stabile. Non è accaduto questo, ma è accaduto comunque che il metodo Pnrr sia valso come precedente per un nuovo modo di distribuire e gestire le competenze, anche quelle non attribuite all’Unione, e soprattutto per indirizzare le scelte politiche dei governi nazionali e dell’Unione insieme.
In altri termini, il NGEU si sta rivelando un tentativo di raggiungere una maggiore integrazione europea, aggirando la mancanza di volontà degli Stati membri di modificare i Trattati.