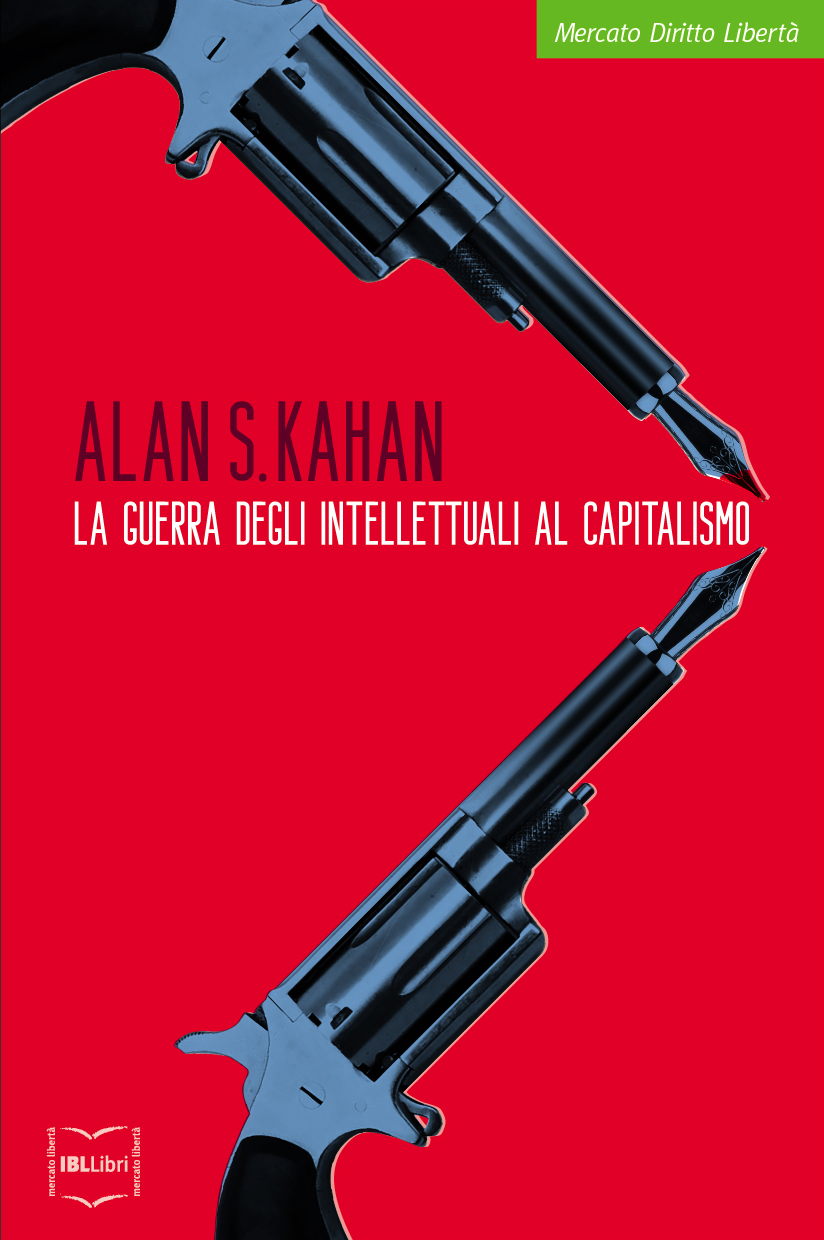
Il rapporto tra intellettuali e capitalismo è sempre stato molto controverso e spesso conflittuale: si è trattato di un lungo percorso nel tempo, caratterizzato da frequenti momenti di attrito e da poche pause di tregua in una guerra combattuta talvolta all’ultimo sangue. Alan S. Kahan, nel suo assai interessante saggio, delinea – con esempi storici, filosofici e letterari – un viaggio cominciato da molto lontano, nel mondo greco-romano, ove compare per la prima volta quell’atteggiamento di iniziale diffidenza per il mondo commerciale, che pure dava vitalità ed estrema mobilità a uomini e merci. Saranno i filosofi i primi intellettuali a interrogarsi sul rapporto tra mente e denaro: a partire dalla “nobile menzogna” di Platone – che tendeva alla realizzazione dell’armonia sociale associata all’eguaglianza economica, al posto del conflitto, basato sulla competizione per la ricchezza – e dalla distinzione aristotelica tra la soddisfazione di bisogni reali e la crematistica, mera accumulazione di denaro, che separa l’individuo dalla comunità, fino a Cicerone – per il quale la ricchezza, pur essendo utile, è comunque disprezzabile – e a Seneca, che elogia la povertà come mezzo per raggiungere l’autonomia e l’indipendenza interiore: tutto il mondo antico si attesta, insomma, su quello che l’A. definisce il “primo divieto”: «non puoi fare soldi (puoi solo averne)» (p. 53).
In epoca cristiana, l’anticapitalismo si accentua decisamente e alla generosità raccomandata dalla tradizione classica viene sostituita la carità, che prevede di dare ad altri (i poveri) le proprie ricchezze: «non puoi avere soldi (devi darli ai poveri)», così recita il secondo divieto. Dai frequenti avvertimenti presenti nei Vangeli – «È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli» di Matteo – al capovolgimento dell’ordine sociale («I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi»), tutto indica che anche lo sforzo di acquisire il denaro è un’azione negativa, ribadita nella prima lettera a Timoteo da Paolo di Tarso: «l’amore per il denaro è la radice di ogni male». La vita buona, insomma, non può contemplare la ricchezza e, come poi verrà dichiarato negli Atti degli Apostoli, la vera vita cristiana ripudia la proprietà privata.
L’esperienza francescana sancisce la distanza netta tra mente (pensiero cristiano) e denaro, anche se un filosofo come Tommaso sottolinea sempre l’utilità del commercio, ma condanna l’usura, già messa al bando dalla Chiesa, soprattutto perché strettamente collegata alla nuova figura del banchiere, solitamente ebreo. In questo percorso conflittuale, anche in ambito protestante si consuma il divorzio tra mente e denaro, nonostante la nota tesi weberiana del rapporto tra capitalismo e calvinismo. Inoltre, in epoca medievale si aggiunge il famoso “divieto del duca” («non fare soldi, prendili e spendili»), tipico del nobile che deve mantenere il suo status sociale per vivere secondo gli ideali cavallereschi dell’epoca. Ma fu soprattutto nell’Europa settecentesca che si andò a configurare l’ultimo divieto, quello democratico, che imponeva: «non puoi avere denaro e non puoi fare più soldi degli altri (non sarebbe giusto)».
È in questa fase storica che contemporaneamente nasce il capitalismo moderno e, insieme, l’innamoramento degli intellettuali per la rivoluzione e per una società non più ideale (com’era la repubblica platonica, governata dai filosofi, oppure il Paradiso religioso ultraterreno, proposto dal cristianesimo), ma realizzata nel “qui e ora”. L’epoca delle rivoluzioni europee aveva introdotto un principio democratico e, nello stesso tempo, aveva quasi paradossalmente avvicinato mente e denaro, perché era innegabile a tutti che lo stesso capitalismo spingesse verso la democratizzazione della società. Nonostante il rifiuto roussoviano e proudhoniano della proprietà privata, l’ottocento fu percorso da quella che l’A. definisce come la “luna di miele” tra intellettuali e capitalismo, una fase in cui l’idea smithiana di “mano invisibile”, insieme al processo di introduzione del concetto di utilità, produsse una sorta di de-moralizzazione del commercio, i cui benefici si estendevano dai singoli individui all’intera società.
È chiaro che, con il procedere del tempo e delle innovazioni, il capitalismo stesso si fece più aggressivo e si assestò spesso su basi di monopolio, fenomeno che diminuiva la sfera di eguaglianza democratica che potenzialmente prometteva. Le idee socialiste e comuniste di Marx ed Engels, insieme al cristianesimo sociale, che si batteva per l’equità sulla terra, e soprattutto il grande spartiacque della prima guerra mondiale riportarono il conflitto ai massimi termini: la rivoluzione russa non era più un ideale da realizzare, ma una realtà concreta, a cui gli intellettuali guardarono con grande favore.
Nello stesso tempo, la Grande Depressione sembrò assestare un colpo mortale al capitalismo, quasi a rendere vicinissima la profezia marxiana del crollo del sistema borghese per eccellenza e della vittoria del proletariato su tutti i fronti. Il disincanto della Grande Guerra portò buona parte dell’intellighenzia a sposare le idee dei regimi forti, dittatoriali e totalitari e, anche dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la Guerra Fredda cristallizzò due schieramenti netti, creando anche una cortina di ferro culturale tra intellettuali comunisti e quelli favorevoli al capitalismo. Una posizione, questa, che si è modificata nel nuovo millennio grazie all’apporto di temi come la globalizzazione e l’ecologismo, che hanno ridato fiato alla critica degli intellettuali contro i nuovi capitalisti del mondo.
Sicuramente, non vi è una soluzione certa per porre fine al conflitto tra mente e denaro. Kahan ricorda che il capitalismo ha bisogno dello sguardo critico degli intellettuali, ma, nello stesso tempo, gli intellettuali oggi non riescono a mettersi alle spalle l’innamoramento per la rivoluzione: non sono più intellettuali “organici” gramsciani in senso puro, ma continuano spesso a manifestare quel forte senso di cecità tipico di chi è “innamorato”. «Anche quando non lo sono più, – scrive l’A. – nella loro disillusione continuano ad amare l’idea di essere innamorati, e da qui nasce la loro nostalgia per il comunismo. […] Gli intellettuali possono essere degli pseudo-aristocratici e pseudo-sacerdoti, ma non sono, con buona pace di Nietzsche, superuomini. Sono capaci di autoingannarsi esattamente come gli altri. Il loro amore per la rivoluzione è una ragione emotiva sufficiente per portare all’autoinganno» (p. 271). Per questo, di fronte a due visioni giudicate dai protagonisti come “incommensurabili”, occorre trovare una forma di distensione e di opposizione leale nella convinzione che entrambi possano in definitiva concorrere al perseguimento sia del bene individuale, sia del bene comune.
da Nuova storia contemporanea, gennaio-aprile 2019