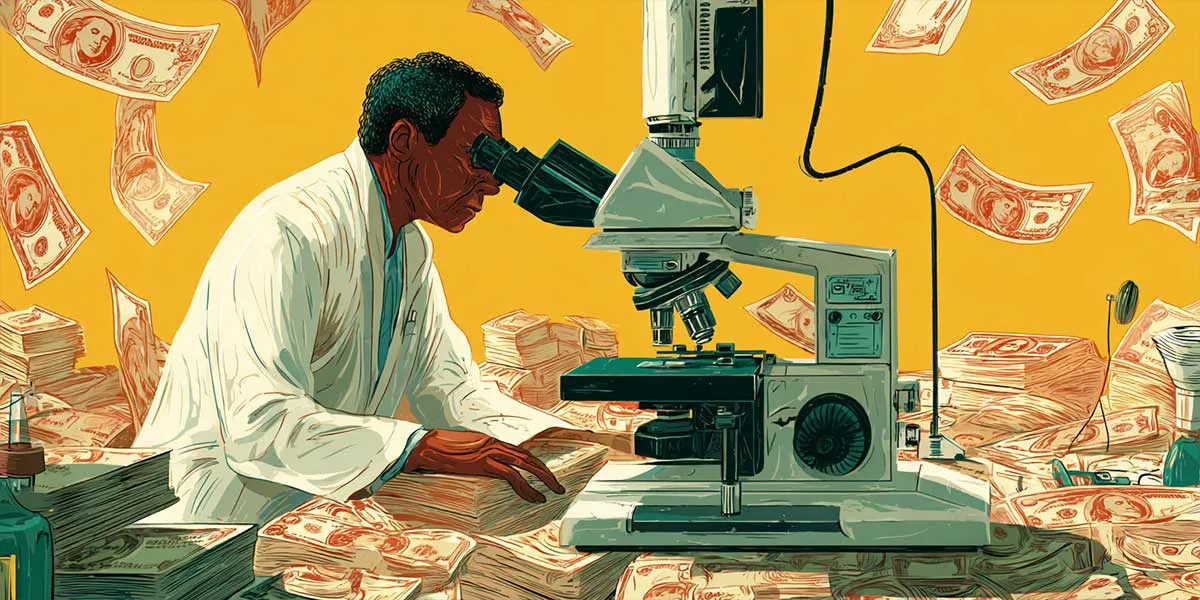
3 Novembre 2025
L'Economia – Corriere della Sera
Alberto Mingardi
Direttore Generale
Argomenti / Teoria e scienze sociali
La minaccia di Donald Trump di un dazio del 100% sui farmaci, con l’eccezione dei generici, è per ora un colpo sparato a salve. L’annuncio ha portato, a settembre, le imprese americane a importare di più — per esempio dalla Svizzera — per accrescere le scorte. Ma allo scoccare della data fatidica (doveva essere il primo ottobre), l’amministrazione ha preferito ingaggiare Big Pharma in un negoziato one-to-one, rinunciando all’affondo in cambio di garanzie sugli investimenti.
Le ragioni per cui Trump ha cominciato la sua guerra commerciale sono note. La globalizzazione avrebbe danneggiato gli Stati Uniti, che pure l’avevano promossa. Avrebbe indebolito la manifattura americana, a causa delle delocalizzazioni. Lo scambio internazionale avrebbe agevolato il trasferimento tecnologico negli altri Paesi, che avrebbero beneficiato dell’innovazione Usa mettendosi a copiarla. In generale, anche realtà tradizionalmente amiche, come le nazioni europee, tenderebbero a vendere a caro prezzo in Usa le proprie merci, a scapito del consumatore americano, mentre mantengono i propri mercati chiusi alle produzioni a stelle e strisce.
È un racconto che per buona parte è fuorviante. Ma non è privo di elementi di verità, e spesso sono quelli meno riconosciuti come tali. Non si può incolpare il governo tedesco se agli americani piacciono le Bmw più di quanto ai tedeschi piacciano le Ford. È vero però che l’Ue è da sempre impermeabile alle importazioni di carne americana.
Il caso della farmaceutica è particolare. La grande concentrazione di aziende d’avanguardia negli Stati Uniti non è dovuta soltanto a ragioni storiche. È anche il risultato del fatto che gli Usa sono l’unica economia di mercato nella quale il prezzo dei farmaci è rimasto sostanzialmente libero. Esistono degli intermediari che negoziano con le imprese farmaceutiche per conto dei grandi compratori, come i gruppi ospedalieri (anche pubblici) e le assicurazioni.
Ma, in linea generale, il prezzo al quale un farmaco entra nel mercato è deciso da chi lo produce. La Food and Drug Administration, a differenza delle equivalenti europee come la nostra Aifa, si occupa esclusivamente di questioni legate alla sicurezza dei medicinali, che determinano la possibilità che essi vengano immessi in commercio. Non fissa un prezzo per legge.
Ciò ha fatto sì che nel corso degli anni il paziente americano sopportasse i costi della ricerca, di cui poi ha beneficiato il resto del mondo. Si stima che circa il 90% dei tentativi di sviluppare un nuovo farmaco vadano a vuoto e che solo il 10% dei composti che entrano nella fase clinica raggiunga poi il mercato. I critici dell’industria sottolineano che, una volta prodotta la prima pillola, i costi di produzione si abbattono. È vero, ma ai costi della ricerca che sta dietro quella prima pillola vanno sommati quelli di tutta la ricerca che non riesce a lasciare la stazione di partenza. È difficile immaginare che qualcuno se ne faccia carico senza essere mosso, anche, dal desiderio di fare profitto.
L’Europa è invece un mosaico di Paesi dove le medicine vengono vendute perlopiù a un prezzo non lontano dai costi di produzione. Lo Stato è monopsonista, cioè monopolizza la domanda, per tutti i farmaci rimborsati. I prezzi sono liberi solo per i farmaci non rimborsati e per i medicinali da banco. Sono cioè soprattutto i prodotti più complessi a essere comprati dalla sanità pubblica, a un prezzo definito dallo Stato stesso.
In più, in Italia come in molti altri Paesi Ue, vige il sistema dei payback: esistono delle soglie di spesa, superate le quali le imprese farmaceutiche devono restituire quanto hanno incassato (in toto o in parte, nel caso dei farmaci ospedalieri) allo Stato. Cioè non solo il compratore fa il prezzo ma pretende che il venditore rinunci a una quota di quel che gli è dovuto, restituendola al compratore, per decisione unilaterale di quest’ultimo. Né il venditore può rifiutarsi di consegnare i medicinali che già sa che non verranno pagati o che lo saranno solo parzialmente, perché ne andrebbe della vita dei pazienti.
Quando definiscono le leggi di bilancio, i politici tendono a osservare che le farmaceutiche non piangono miseria e quindi confermano, anno dopo anno, il medesimo sistema. I conti pubblici ne beneficiano, anche se attraverso un meccanismo perverso. I tecnici della sanità amano parlare di «appropriatezza» dei trattamenti e biasimare la tendenza dei medici a prescrivere analisi e trattamenti in eccesso, almeno in parte per lenire le ansie dei pazienti. Ma non c’è molto di appropriato nel combinato di tetti di spesa e misure di rimborso. Il semplice fatto che si debba regolarmente ricorrere a queste ultime suggerisce che i primi sono fissati a un livello incongruo.
Il problema con cui l’Europa e l’Italia dovranno scontrarsi è il cambio di scenario determinato dal trumpismo. Non sarà attraverso un dazio del 100%, ma Trump vuole ridurre il prezzo dei farmaci per gli americani. I costi della ricerca però non è detto che scendano. Nella situazione attuale, ciò significa presumibilmente meno ricerca e meno farmaci innovativi, a meno che anche gli altri Paesi si facciano carico della copertura di una parte dei costi per lo sviluppo di nuove medicine.
L’Italia, con una popolazione in rapido invecchiamento, ne risentirebbe più di altri. Il rapporto di tutta l’Europa con la regolazione del prezzo dei farmaci, in prospettiva, deve per forza cambiare. Chissà che un Paese di forte tradizione farmaceutica come il nostro non possa per una volta anticipare questi processi.